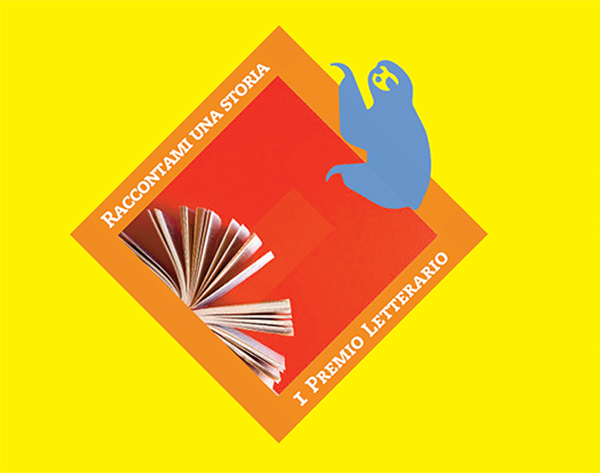
Ci incontravamo tutte le sere in quel bar che si ostinava a non voler essere un bar, forse per questo la scritta “Latteria” sopra lo stipite della porta resisteva, ogni giorno più arrugginita e decadente.
«Marco fa la notte?»
«Ma sono già le sette?»
«Luca viene oggi?»
Ci rassicurava rivolgerci sempre le stesse domande, erano stralci di brevi storie raccontate al capezzale di un bancone.
Laura ripeteva che non avrebbe bevuto niente di alcolico, diceva che in settimana “non aveva senso”; sapevo cosa voleva dire, o almeno credevo di poterlo intuire. Dopo il bar sarebbe tornata a casa dalla madre e dalla nonna, avrebbe cenato con loro, poi avrebbe aiutato sua madre a metter a letto la nonna e sarebbe andata a dormire anche lei. Non avrebbe neppure acceso la tv, sperando che la stanchezza e la noia del giorno le chiudessero gli occhi, prima che la testa si sintonizzasse su un qualsiasi pensiero.
Io e Elia bevevamo molto, invece. Che l’alcool per noi aveva sempre un senso, ci sembrava che aggiungesse senso a quello che dicevamo, a ciò che facevamo e addirittura a tutto quello che tacevamo. Elia non si spogliava neppure d’inverno, arrivava con un piumino di almeno due taglie più grandi, una sciarpa di lana che gli aveva fatto sua madre e un cappello da baseball e rimaneva così tutto il tempo.
«Ma non sudi?» gli chiedevo.
«Io non sudo mai» rispondeva. E infatti non sudava, o meglio non puzzava. Se poi sudasse lo sapeva solo lui.
Io e Marco a volte ci mettevamo a giocare a carte con i vecchietti del bar, ci sentivamo altruisti ad onorarli della nostra presenza giocando in coppia con loro. Anche se, a dire il vero, i vecchi giocavano molto meglio di noi, si ricordavano le carte che erano già uscite e non davano quasi mai scopa.
Laura e Camilla si sedevano al tavolo con noi, segnavano i punti, erano efficienti come quasi tutte le donne che conoscevo: non si sbagliavano mai e non ci permettevano di barare. Erano giuste, loro. E mentre seguivano la partita e stavano attente alle scope e ai denari di ciascuno, le sentivi sussurrarsi frasi criptate, parole in codice che nella nostra mente di ragazzi poco fantasiosi dovevano rappresentare i nomi dei tipi che si erano scopate nel fine settimana. Di scopare con uno di noi non ci avevano manco mai pensato, questo era certo.
A me piaceva un po’ Laura, ma mi guardavo bene dal dirglielo o anche solo dal farmi sorprendere a guardarla. Mi sembrava che tutto quello che era legato ai sentimenti andasse come minimo protetto, se non occultato o negato. Avevo impresse nella mente le parole di mio padre, mentre mi passava una sigaretta e tirava dalla sua «Se si accorgono che ci tieni, sei fottuto. Per un complimento di troppo, sono in gabbia da vent’anni».
Una volta ero uscito con una, ma solo per togliermi di dosso l’onta della verginità e potermi piazzare tra la massa dei miei coetanei che a quattordici anni l’avevano già fatto. Alla fine dei nostri fugaci rapporti non eravamo contenti né io, né lei: a volte, dopo aver fatto l’amore, ci chiedevamo scusa. Però almeno ci rispettavamo, non ci eravamo mai sputtanati in giro.
In generale eravamo molto più interessati all’alcool e alla coca che alle ragazze. Ma sapevamo che ci erano utili, erano loro che spintonavano Elia fuori dal locale quando ubriaco fradicio importunava i clienti del bar o che accompagnavano a casa me quando manco a piedi ci sarei mai potuto arrivare. Mi chiedevo spesso perché lo facessero, per quale ragione si prendessero l’ingrato compito di proteggere dei tipi inutili come noi. Eppure, pensandoci bene, me lo sono sempre chiesto anche di mia madre, quando la vedevo nascondere le sigarette a mio padre o aggiungere acqua alla sua grappa.
La coca ce la dava un tipo sulla cinquantina, uno di un paese vicino. Ci prendeva per il culo con frasi patetiche come «Solo a voi la vendo a questo prezzo» oppure «Per trovarla così buona dovreste espatriare». Noi non gli credevamo e non ribattevamo niente, alla fine non ci fregava molto che fosse davvero roba buona e quello che ci chiedeva potevamo pagarlo. Tutto qui. All’inizio era una cosa del sabato sera, poi Elia aveva cominciato anche al venerdì e io gli ero andato dietro. Ultimamente Marco diceva che farlo alla domenica lo aiutava ad affrontare meglio la settimana in fabbrica e noi, che andavamo ancora a scuola, gli facevamo compagnia lo stesso. Laura e Camilla non pippavano, dicevano che un loro amico ci era rimasto sotto la prima volta e adesso sua madre se lo portava in giro mano nella mano e gli asciugava la bava con un fazzoletto che teneva sempre in tasca.
La cosa strana era che prendevamo la coca prima di entrare in discoteca come se dovessimo poi divertirci un sacco là dentro, ma in realtà quello che facevamo era arrivare in discoteca, cercare un bagno per farci un’altra riga, uscire nel parcheggio e rimanere lì tutta la notte a parlare, sovrapponendoci l’un all’altro, urlando, spintonandoci e mandandoci al diavolo senza una ragione. Il nostro sballo era una logorrea senza fine, sterile e sconnessa; i nostri discorsi erano coperte bagnate tirate fino al limite sui fili di relazioni che si mantenevano in piedi per miracolo. O per disperazione.
Prendevamo la coca per stare fuori dalla discoteca, fuori dalla vita dei nostri coetanei, aggrappati alle nostre parole sconclusionate che uscivano d’impeto dalla bocca per poi ricacciarsi dentro in fretta, incapaci di arrivare agli altri. Quando le ragazze uscivano, salivamo sul Peugeot di Marco tutti e sei, loro si prendevano in braccio e noi quasi sempre ci addormentavamo, i cappucci delle felpe calati sulle facce, le mani sotto alle ascelle. Non so perché ma mi svegliavo sempre quando in macchina eravamo rimasti io, Luca e Marco: loro due davanti, io dietro.
Marco diceva che non si poteva continuare così, che passavamo dal lunedì al giovedì a bere e dal venerdì alla domenica fuori da quella cazzo di discoteca, che eravamo degli stronzi e che stavamo sprecando le nostre vite. A fine serata si vergognava sempre un po’ di essere il maggiorenne del gruppo e ripeteva che il fine settimana dopo sarebbe cambiato tutto. E intanto mandava messaggi al tipo della coca per ricordargli che ora la compravamo anche alla domenica. Io gli davo ragione, dicevo che eravamo degli stronzi assoluti, ma che vivendo dove vivevamo non potevamo che sprecare le nostre vite. Che lo spreco era cominciato nascendo lì. Luca, invece, non diceva quasi mai niente.
Una volta, arrivando in prossimità del fiume, aveva aperto il finestrino, anche se era inverno e io e Marco lo avevamo insultato in coro perché richiudesse subito. Aveva messo la testa fuori e urlato «Lì, lì”, indicando con la mano. Poi ci aveva raccontato che una volta era andato a pescare con suo padre e, proprio mentre stava tirando su un pesce, era arrivata una folata di vento e gli aveva portato via il cappello. E lui si era spaventato tanto che aveva perso non solo il cappello ma pure il pesce e suo padre si era arrabbiato.
A noi sembrava una storia tanto stupida che non capivamo perché ci avesse tenuto a raccontarcela, non era triste e non faceva neanche ridere. Quando Luca era sceso Marco mi aveva detto che forse riteneva importante quel ricordo perché suo padre era morto che lui era piccolo.
A partire da quel giorno, ogni volta che passavamo di fianco al fiume Luca appoggiava la testa contro il finestrino, a volte faceva un cenno col capo come a dire “È lì che è successo”. E io avrei voluto dirgli che mi spiaceva che suo padre fosse morto, ma che si era comportato proprio da stronzo con lui che, oltre ad avere perso il pesce e il cappello, aveva dovuto sorbirsi anche la sua sfuriata.
Di notte facevo fatica a dormire, specie di ritorno da quelle serate che mi sembravano piene e vuote nello stesso modo: piene di gente, di alcool e soprattutto di parole. Parole gridate dai banconi o dai finestrini, parole lanciate più in alto di quelle degli altri nei parcheggi, parole che sbattevano contro le portiere dell’auto di Marco. Ma il vuoto sembrava comunque riuscire ad inghiottire pezzo a pezzo quelle isteriche serate sempre uguali a se stesse: erano vuoti i nostri sguardi mentre ci lanciavamo richieste o accuse che manco sapevamo decifrare e soprattutto c’era un grande spazio vuoto che ci separava dagli altri, anche dai nostri amici stessi, e più in generale da tutto il resto del mondo.
Per riuscire ad addormentarmi contavo di tutto: i secondi che durava il respiro rantolante di mio padre prima di arrivare al climax del suo incessante russare, i colpi che gli dava mia madre per farlo smettere, i rintocchi dell’orologio Ikea appeso in cucina. Le pareti del nostro alloggio erano così sottili che avevi l’impressione di essere nella tua stanza e contemporaneamente in quelle di tutto il resto della casa. Sdraiato sul tuo letto potevi controllare anche quello che succedeva negli altri ambienti, che lo volessi o meno. Erano case senza privacy, senza segreti e, quindi, senza alcuna dignità.
In quei momenti mi sentivo come quando da piccolo nascondevo la testa tra le coperte perché il lupo cattivo o il mostro dei giocattoli o qualsiasi altro personaggio inquietante avesse tirato fuori mia madre per spaventarmi, non mi trovassero. Ora, ormai grande, mettevo la testa sotto al cuscino e ce lo premevo forte sopra perché alcune delle frasi che avevo ascoltato quella sera non trovassero spazio per entrare o perché certi sguardi non arrivassero a ricacciarsi dentro ai miei occhi. Parole e sguardi che sembrava mi fossero scivolati addosso come il getto della doccia, ora tornavano ad attaccarmi nel buio della stanza, approfittando della solitudine e dell’immobilità.
Cominciavo a rilassarmi solo quando sentivo mia madre entrare in cucina e cominciare a spostare cose, richiudere cassetti, mettere su il caffè: nel rumore riuscivo a prendere sonno, il silenzio non era mio alleato.
E poi è arrivato un altro fine settimana, al venerdì non sono uscito perché avevo la febbre; ce l’avevo anche al sabato, ma di passare due serate di fila in casa non se ne parlava neanche. Appena sono entrato al bar ho sentito una sensazione strana, qualcosa che non mi sapevo spiegare, ma che mi ha fatto salire l’ansia. Subito dopo è arrivato Elia che era lo stesso di sempre. Poi, però, è entrata Laura ed è bastato un banale dettaglio per peggiorare il mio stato d’ansia: aveva delle scarpe nuove, col tacco di almeno tre-quattro centimetri più alto del solito. Questa cosa delle scarpe nuove col tacco mi si è piazzata sullo stomaco e immediatamente mi ha fatto pensare ad un nuovo incontro. Le risatine che scambiava con Camilla, facendole vedere il cellulare, e le ripetute entrate al bagno per rifarsi il trucco hanno confermato del tutto i miei sospetti.
Poi è arrivato Marco che era incazzato come non l’avevo quasi mai visto perché avevano cominciato a lasciare a casa della gente in fabbrica e lui diceva che sarebbe stato uno dei prossimi. Ce lo diceva come se in parte fossimo noi i responsabili del suo imminente licenziamento, tanto è vero che ad un certo punto ha cominciato anche a urlarci che dovevamo dargli i soldi della benzina e che si era rotto il cazzo di farci da taxista. Elia gli è scoppiato a ridere in faccia, io sbirciavo Laura e Camilla cercando di capire se stessero guardando delle foto o leggendo dei messaggi.
Per ultimo è arrivato Luca che era stranamente allegro. E non era manco ubriaco, era solo allegro. Forse questa è stata la cosa che mi ha messo più di cattivo umore. Ha addirittura voluto offrire un giro di chupitos a tutti, diceva che era una bella serata, che dovevamo brindare.
Fuori dal parcheggio quella sera ciascuno era nel suo mondo, non ci andava neanche di urlarci addosso: Marco imprecava da solo contro la fabbrica, i suoi, il paese e chiunque altro gli venisse in mente, io bevevo più del solito per ovvie ragioni, Elia ad un certo punto è andato a dormire in macchina, Luca canticchiava per conto suo con un sorriso da imbecille stampato in faccia.
Quando ho visto le ragazze uscire dalla discoteca, mi sono infilato di corsa in macchina e ho finto di addormentarmi, nessuna voglia di vedere il rossetto sbavato di Laura e la sua espressione compiaciuta prendersi gioco di me. Prima di scendere dall’auto, lei ha detto che l’indomani non sarebbe passata dal bar perché “aveva da fare”. Io mi sono lasciato scappare “Troia”, neanche tanto sottovoce, alla fine l’unica che poteva notarlo o arrabbiarsi era Camilla, ma era già scesa. Poi abbiamo scaricato anche Elia e siamo rimasti io, Marco e Luca; arrivati all’altezza del fiume Luca per fortuna non ha fatto commenti e non si è neppure voltato verso il finestrino. Poco prima di arrivare a casa, però, si è girato verso di me, che ero seduto dietro, poi ha guardato anche Marco e ha detto «Parliamo un po’?». Marco l’ha mandato affanculo senza pensarci un attimo e io non gli ho manco risposto.
Quella notte, nelle poche ore che ho dormito, ho sognato che mio padre stava con Laura e mi sono svegliato con la sensazione che la febbre mi fosse salita ben oltre quaranta. Piuttosto che passare in casa la domenica sera, ho deciso di uscire lo stesso. La domenica la casa era troppo piccola per contenere la tristezza di tutti, c’era bisogno che qualcuno portasse fuori la sua. Ed ero sempre io. Avrei voluto avere un altro posto in cui andare per la storia di Laura. Ma di fatto un altro posto non ce l’avevo.
Ancora prima di entrare al bar l’ho vista, seduta su uno sgabello, intenta a scrivere un messaggio; quando ha sollevato il viso per salutarmi, mi sono accorto che aveva gli occhi rossi e gonfi. Ho pensato subito “l’ha mollata” e ho sentito come se il petto mi si stappasse di colpo, proprio come una bottiglia di spumante. Ho fatto finta di niente, ho ordinato un cocktail per brindare in solitaria a quell’epilogo insperato.
Dopo poco è arrivata Camilla che ha tenuto Laura abbracciata almeno un paio di minuti e poi Marco e Elia; Marco aveva litigato coi suoi perché erano convinti che la fabbrica volesse lasciarlo a casa per tutte le volte che non si era presentato al lavoro senza avvisare. Elia ha cominciato a dirgli che bastava una volta per licenziarlo e si sono messi a bisticciare.
Io fingevo di ascoltarli e intanto spiavo le ragazze, cogliendo al volo gli insulti di Camilla, “bastardo”, “falso”, sicuramente indirizzati al tipo della discoteca. E ogni volta che Camilla se ne usciva con qualche nuova ingiuria, Laura piangeva di più, come se gli insulti fossero rivolti a lei e non al tipo. Per un attimo ho anche pensato di avvicinarmi e dirle qualcosa, ma non sapevo proprio da dove cominciare, il dialogo più lungo che avevo avuto con lei era stato quando era morto suo nonno e le avevo detto una roba tipo «Mi dispiace, so che ci tenevi tanto». Magari potevo utilizzare la stessa frase, l’altra volta aveva fatto effetto, mi aveva addirittura ringraziato e abbracciato. Ma non mi andava di fingere che mi dispiacesse, non ce la facevo proprio.
Poi, ad un certo punto, Gianni, il padrone del bar, approfittando di un momento di silenzio ha guardato in sequenza me, Elia e Marco e ha detto «Ah, Luca se n’è andato». L’ha detto mentre ci riempiva i bicchieri, senza aggiungere altro, come se stesse commentando una notizia del tg. Marco è stato il primo ad aprire bocca, ha detto «Che pezzo di merda, alla fine se l’è svignata davvero», Laura si è messa a piangere più forte, Elia ha farfugliato «Quello è tutto matto». Non lo so cosa stessero immaginando gli altri in quel momento, io ho pensato che alla fine Luca avesse deciso di riprendersi quel fottuto cappello e che la sera prima era così felice perché finalmente aveva trovato un altro posto in cui andare.
Dominique Campete