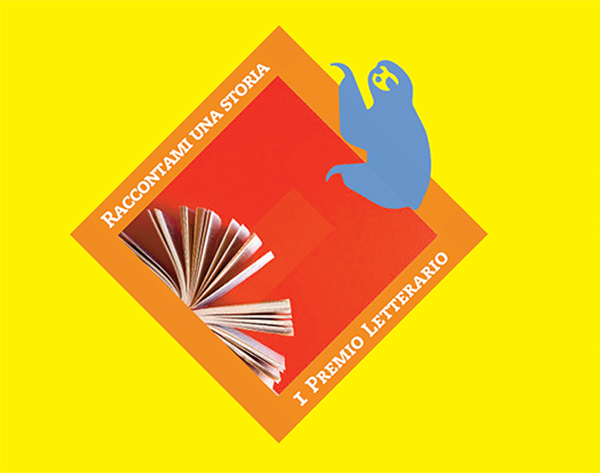
Gli inverni napoletani erano caratterizzati da un clima mite. Le giornate venivano riscaldate a malapena per via delle basse temperature. A soli dieci anni, mi armavo di cappotto e mi recavo a lavoro. Allora i tempi erano difficili: era il periodo del dopoguerra. La fame arricchiva i popoli colpiti. Io e le mie piccole sorelle già lavoravamo; è così che aiutavamo l’economia della nostra famiglia. Io ero una piccola operaia in una fabbrica. La mia mansione era: cucire, con minuzia, gli orli dei guanti. Una bambina come tante che al posto di giocare con bambole di pezza, era cresciuta per dar manovalanza ad una popolazione messa in ginocchio.
Di domenica io e la mia famiglia ci recavamo nella Chiesa Cattolica Evangelica per partecipare alla Santa Messa. C’era un giovanotto che suonava la fisarmonica ad ogni cantico.
Ed io rimasi incantata da una bellezza introvabile.
Incontrai lui: Giovanni, figlio del pastore che proclamava la parola di Dio; aveva poco più che quattordici anni.
Lui faceva parte di una famiglia con ben diciotto figli: tutti credenti. Quando il pastore si accorse che io ero quella bambina che, con zaino in spalle, mi recavo alla fabbrica di fronte la loro abitazione: comunicò alla mia dolce mamma che potevo mangiare un pasto quando avevo la mia ora libera. Non poté far altro che accettare quell’allettante offerta in quanto attraversavamo un periodo di crisi e non potevano assicurarmi altrettanto.
Ero innamorata del loro primogenito: moro, alto, magrolino e lavoratore. Durante la messa, non mi facevo sfuggire la mia occasione: sgattaiolavo tra la folla di persone per dargli la mano e dirgli: «Pace Fratellino».
In comunità dirci “Pace” era la nostra forma di rispetto più nobile. Quando sapevo che era presente anche lui, indossavo: la mia camicetta rosa decorata con merletti, la mia gonna ed un paio di scarpe bianche con un fiocchetto decorativo regalatemi dal mio adorato papà.
Quello era il mio modo per farmi notare da quel giovanotto ammirato anche da altre fanciulle.
Ero innamorata di lui.
Frequentavo ogni giorno la casa paterna, solo per avere la possibilità di poterlo vedere. Per mia sfortuna però non succedeva mai perché quando io ero libera, lui era impegnato col suo lavoro.
Speravo si accorgesse di me. Ma al suo posto un giovane si recò da mio padre a chiedergli la mia mano. Io non lo volevo, non ero innamorata di lui. Quando mio padre mi comunicò della proposta di matrimonio fatta contro il mio volere e senza che io ne sapessi nulla; mi ribellai: “Non lo conosco! Non sono innamorata di lui.” Gli urlai contro. Mi rinchiusi in camera a piangere. Il mio cuore voleva Giovanni.
Il silenzio mi accompagnava a casa ogni volta che il mio orario lavorativo giungeva al termine. La speranza che lui si accorgesse di me, stava svanendo.
Quando stavo per arrendermi, Giovanni mi corse dietro, affannato mi disse: «Amalia fermati, devo parlarti!».
Il mio cuore balzò in gola. Non sapevo cosa aspettarmi da quel ragazzo che mi faceva brillare gli occhi come la luna su un mare estivo.
Mi prese la mano e mi disse: “Amalia sento che provo qualcosa di forte per te! Mi sento innamorato!”
Ero lusingata, non riusciì a proferire parola in quell’istante. Poi feci un grosso respiro e risposi: “Ti farò sapere tra una settimana!”
Io gli avrei detto subito di si e gli avrei gettato le braccia al collo, ma preferiì arricchire la sua curiosità.
Restò sbigottito dalla mia risposta a bruciapelo. Senza fiatare, corse verso casa sua e saltò sul suo motorino laccato rosso. Sfrecciò davanti ai miei occhi.
Forse lo avevo offeso non accettando subito la sua proposta? Forse avrei dovuto dirgli di si? Forse non me lo chiederà più. Sarà corso da un’altra.
Presi a camminare di nuovo come stavo percorrendo quel viottolo in precedenza al suo improvviso arrivo con un forte rimorso. Le lacrime mi salivano dal cuore e si affacciavano sugli occhi ma non avevano il coraggio di scendere per rigarmi il viso.
Rincasai ed una voce familiare echeggiava per il corridoio. Una forte emozione mi saliva dallo stomaco. Avevo come spasmi muscolari all’altezza dell’addome. Sentivo la voce di Giovanni provenire dal salone o era una mia allucinazione?
Mi affacciai sull’uscio della porta e lo vidi seduto accanto al tavolo, in sala da pranzo con i miei genitori, intento a spiegare il suo sentimento per me: «Vostra figlia vuole me, me lo ha confermato poco fa, sulla strada di ritorno dal lavoro!». Insisteva.
Non potei far altro che confermare quello che era il mio sentimento per lui. Il mio cuore aveva subito come un piccolo precesso, dovevo dire la verità: io amavo Giovanni.
Nel giro di pochi minuti mi trovai fidanzata col mio grande amore.
Iniziò a frequentare la mia umile abitazione insieme alla sua fisarmonica: intento a insegnare a suonare mio padre e mio fratello maggiore, Antonino.
Di tanto intanto chiedeva a mia madre di preparare un caffé d’orzo con biscotti per avere qualche occasione d’intimità con me: baci furtivi dati da un passaggio e l’altro dei miei fratellini che giocavano rincorrendosi da una stanza e l’altra.
Dopo circa un anno Giovanni mi fece la fatidica proposta di matrimonio, scocciatosi della situazione domestica.
«Amalia ci dobbiamo sposare! Io non posso più desiderare di accarezzarti. Vorrei toccare liberamente il tuo viso senza cercare di allontanare nessuno».
Accettai senza esitare un istante.
Nel giorno del nostro matrimonio furono invitati tutti i fratelli e sorelle della comunità evangelica. I nostri genitori non esitarono a spendere qualcosina di soldi per non farci mancare un buffet nuziale degno di una cerimonia reale.
Un cruccio però mi accompagna tutt’oggi. Non ho nemmeno una foto che ritrae i nostri visi giovani e gioiosi di quel giorno. La nonna di mio marito non volle farci contattare nessun fotografo per immortalare quei momenti per via della fede che praticavamo. Tutto è ben nitido nei miei ricordi ma non negli album nei cassetti dei mobili in sala da pranzo.
Una volta marito e moglie demmo sfogo al nostro amore, quel desiderio sommerso per troppo tempo. Accarezzavamo i nostri visi liberamente. Svegliarsi accanto a lui risultava un’emozione straordinaria. Avevo raccolto il mio colpo di fulmine con la mia semplicità e di passare dall’essere bambina all’essere donna con l’uomo della mia vita. Da lì a poco l’idea di far crescere la nostra famiglia era forte. Decidemmo di mettere al mondo un figlio.
Lo portai in grembo fino a sette mesi per vederlo morto accanto al mio letto d’ospedale, non potendo allattarlo o sentire il suo odore. Demmo degna sepoltura al corpicino.
Ero dispiaciuta ed amareggiata per quell’accaduto. Ci volle un pò per riprendermi.
Giovanni decise di riprovarci, ma non arrivai neppure ai tre mesi che morì anche l’altro.
Non seppi mai se fosse un bambino o una bambina, per me era lo stesso. Il mio amore sconfinava ugualmente.
Quando ormai persi tutte le speranze, arrivò lui: «Complimenti Signora! E’ sano e forte. Come vuole chiamarlo?».
Tra lacrime di gioia immensa pronunciai «Ciro, si deve chiamare come mio padre!».
Dopo circa un anno mi resi conto di essere di nuovo incinta. Questa volta era una piccola principessa. Mio marito era pazzo di lei ed era intenzionato di chiamarla come sua madre. Le doglie mi arrivarono di sera e per tutta la notte fui piegata in due da dolori lancinanti.
Allora si partoriva nelle abitazioni e veniva a casa l’ostetrica per preparare al meglio le donne che partorivano. Mio marito andava e veniva dalla camera da letto al bagno per portare l’occorrente alla Signora: asciugamani, garze e disinfettanti. Verso le ore sei del mattino, un gemito di dolore sentì Napoli. Era nata la mia bambina. All’alba, di un giorno di fine ottobre, nacque una rosa. Era bellissima, con due occhi neri che illuminavano la stanza. «Come chiameremo questa bambina, Signora?».
«Rosalba!» Le risposi guardando la bambina ammirata dalla sua tanta bellezza.
«Noo!!» rispose mio marito. «Si deve chiamare Giuseppina! Come mia mamma!».
«E così sia!». Anche se dispiaciuta, dovetti accontettare il suo desiderio.
I bambini crescevano e con l’andare degli anni erano vispi e pieni di energie. Fin quendo il Comune di Napoli non ci affidò un’ abitazioni in un condominio di un palazzo affollato di famiglie.
Lì i miei figli ebbero occasione di fare nuove conoscenze e crearsi nuove amicizie e perché no! Anche piccoli amori passeggeri. Infondo il mio era nato a dieci anni quando mio marito ne aveva all’incirca quattordici.
La vita scorreva felice anche con ostacoli che una vita matrimoniale ti pone lungo il cammino della vita.
Provai emozione quando mio figlio si arruolò nella caserma militare partenopea e mia figlia presentò suo marito: regalandomi tre nipoti stupendi; la mia gioia più grande.
Improvvisamente tutto cambiò.
Alla soglia dei miei quasi sessantotto anni ho percorso la strada della Clinica dove accoglie mio marito, accompagnato da mio nipote: il fidanzato di mia nipote, la maggiore.
Ogni giorno prendo le sue bellissime mani e gli racconto la storia della nostra vita insieme.
Giovanni all’età di settant’anni è stato colpito da una malattia che ha portato tanto dolore: il morbo di Alzheimer.
Il morbo di Alzheimer è un tipo di demenza senile che provoca problemi con la memoria, il pensare e il comportamento. Generalmente, i sintomi si sviluppano lentamente e peggiorano con il passar del tempo, diventando talmente gravi da interferire con le attività quotidiane.
Ho cercato di accudirlo da sola fin quando ho potuto: ho imboccato mio marito quando mangiava un pasto caldo, mi obbligava a servire il pasto alla mamma e alla nonna morte anni addietro, l’ho lavato, lo vestito ma non riconosceva i miei atti d’amore. Col trascorrere del tempo però anche le mie patologie hanno frenato il mio solidale amore nei confronti del mio grande uomo.
Temevo di averlo perso quando un’embolia polmonare indebolì le vie respiratorie.
Ma la morte non ha potuto portarmelo via.
L’amore che io e i miei cari provavamo per lui è stato talmente grande che ogni tentativo è stato utile a tenerlo in vita.
Ogni giorno in clinica gli raccontavo la nostra vita insieme: ma lui serrava gli occhi, come se io fossi una sconosciuta. Non si ricordava più chi fossi.
La mia forza di donna, moglie madre mi rincuorava e mi faceva andare avanti, giorno dopo giorno.
Dentro di me ho trovato la forza per rimboccarmi le maniche ed amarlo come il giorno del nostro primo incontro.
Amarlo per me è stata la mia missione di vita. Crescere con lui, creare una famiglia. Ricordargli che ad uno ad uno si sono presentati come germogli in un campo privo d’acqua come quello che ci aveva lasciato, in eredità: la guerra.
Alcuni nostri cari non ci sono più, è vero, ma abbiamo dato vita a nuove vite come la figlia della mia ultima nipote.
Quando arrivò la fatidica telefonata che era sul pendio della morte, il mio cuore fu stretto da una morsa di ferro. Amavo quell’uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.
Un uomo che ha lottato tra la vita e la morte per due mesi. Voleva restare con noi, era la sua anima che glielo imponeva, non più la razionalità del suo cervello: ormai quello era bello che andato.
A settantadue anni Giovanni si è spento lasciando, al suo posto, un vuoto.
Siamo stati accanto a lui, gli abbiamo tenuto la mano fino all’ultima esalazione di respiro.
Ora il suo posto è una fredda bara di un triste cimitero, fatto di vite finite.
Oggi tutto quello che posso dire è: «Giovanni grazie per: i cinquantadue anni insieme a te, grazie per tutto quello che mi hai regalato, grazie per il tempo che mi hai dedicato. Giovanni anche se il morbo ti ha tolto quello che di più prezioso esiste, il tempo, ed è proprio nel tempo resti!».
Silvana Carolla